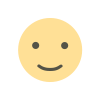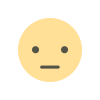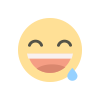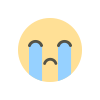Una colata di pistacchio ci seppellirà
Siamo esposti continuamente al cibo: sui social, in televisione, su Youtube. Questo nuovo modo di introiettare le pietanze degli altri ha comportato un cambiamento negli usi e nei consumi che coinvolge addirittura il turismo. Perché il libero mercato miete vittime anche quando si parla di cibo affabulando le masse, e di questo passo una colata di pistacchio ci seppellirà. L'articolo Una colata di pistacchio ci seppellirà proviene da THE VISION.

Tra gli scritti di Ammiano Marcellino, prestigioso storico romano del IV secolo, c’è una frase che potrebbe sembrare criptica, quasi ambigua: “Dove si cura troppo il cibo, ivi si cura poco la virtù”. Non si sa bene se fosse una critica ai banchetti usati dalle classi agiate come ostentazione di ricchezza o qualche metafora che adesso non riusciamo a cogliere, ma se Ammiano fosse vivo adesso, probabilmente tra uno scroll e l’altro su Instagram rincarerebbe la dose scrivendo un trattato sul food porn come specchio della vacuità dei nostri tempi. Il termine “food porn” non ha un’origine specifica. È stato usato in principio a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta per descrivere la rappresentazione glam del cibo attraverso fotografie, pubblicità, programmi di cucina dove le pietanze venivano mostrate come attraenti alla vista, da “mangiare con gli occhi”. Con gli anni l’espressione ha assunto significati spesso errati, come quando viene associata al junk food, al cibo spazzatura ipercalorico e a tutte le porcate da sgarro poco salutari. In realtà, seguendo l’accezione originaria, potrebbe rientrare nel food porn anche un’insalata healthy, se mostrata attraverso canoni estetici appaganti, con la vista a superare il gusto e “l’instagrammabilità” del contenuto in questione a svettare su tutti gli altri parametri. In tal modo otteniamo un cibo idealizzato che ha modificato anche la funzione sociale del mangiare. Non esistono ovviamente statistiche ufficiali a riguardo, ma in qualsiasi ristorante è probabile che oggi, nella stragrande maggioranza dei casi, una persona fotografi il piatto prima di assaggiarlo così da poterlo postare sui social. Il cibo dunque deve essere più colorato, più bello, più accattivante a prescindere dal sapore. I ristoratori lo sanno e si adeguano a questa tendenza.

Il fenomeno in realtà parte da prima dell’avvento dei social. Già nelle pubblicità televisive il cibo era rappresentato in una forma diversa da quella a cui eravamo abituati tutti i giorni. Ricordo una mattina di tanti anni fa, quando nella mia scuola elementare vennero a fare un casting per la pubblicità di un noto prodotto per bambini. Per intenderci, il dessert-yogurt alla frutta di diversi colori. Presero una ventina di alunni a caso, compreso me, e girammo lo spot pubblicitario. A due bambini in primo piano con i vasetti del prodotto in mano, il regista disse: “Mi raccomando, non mangiatelo, non è commestibile”. Scoprii dunque che esistevano figure professionali che creavano per le pubblicità repliche dei prodotti, però più cremosi, più colorati, più soffici, e che quindi tutte le merendine che guardavo in televisione erano finte. Oggi, sui social, il cibo mostrato è vero, solo che il meccanismo di abbellimento del prodotto è il medesimo degli spot pubblicitari, rendendo anche il food porn una mercificazione delle pietanze.

Siamo esposti continuamente al cibo. Sui social, in televisione con i reality a tema culinario che hanno reso gli chef delle rockstar e i concorrenti smaniosi di parteciparvi come succedeva vent’anni fa al Grande Fratello. Su Youtube il cibo tira perché si innesca nel nostro cervello un desiderio di osservare gli altri anche solo mangiare – come succede con i mukbang e persino con gli ASMR. Nel libro Aggiungi un selfie a tavola. Il cibo nell’era dei food porn media, gli autori Sebastiano Benasso e Luisa Stagi spiegano come osservare gli altri nell’atto di mangiare sia paragonabile al voyeurismo sessuale, con il fruitore del contenuto che non compie l’azione ma la sua sublimazione. Come nelle fantasie pornografiche, spesso anche per il cibo guardiamo contenuti su prodotti che non possiamo mangiare – perché per esempio siamo a dieta. Può sembrare una forma di masochismo, ma ad alcuni placa la fame e riproduce una soddisfazione quasi telepatica, come se per immedesimazione anche noi mangiassimo le stesse cose. E se non sono mukbang e ASMR si tratta di video di food blogger che recensiscono tipologie di cibo di ogni genere. Questo nuovo modo di introiettare il cibo degli altri ha comportato un cambiamento negli usi e nei consumi che coinvolge addirittura il turismo.
In un’epoca in cui tutto è un trend, può capitare infatti che una tendenza generi mutamenti nei menu e l’apertura di locali a tema. Il guacamole in Italia probabilmente avrebbe meno adepti senza i social, e allo stesso modo alcune ricette non sarebbero portate all’esasperazione. La carbonara esiste da prima di Internet, ma non la “carbocrema”, e dunque il mix tra uovo e pecorino diventa sempre più arancione, sempre più cremoso. Per non parlare dell’uso smodato del pistacchio. Rigorosamente di Bronte, anche se in realtà una gran parte viene dal Pakistan perché il piccolo comune etneo non può produrre quella quantità immane del prodotto. Colate di pistacchio sui panettoni, sui waffle, sulle torte, e va forte anche la declinazione salata. Nella mia città, Catania, il pistacchio è ormai diventato una piaga sociale, con i turisti che vengono dopo aver visto un reel su Instagram della pizza pistacchiosa o del cannolo verde smeraldo. Piccolo appunto per i profani: più il pistacchio è d’un verde acceso, più è “chimico” per via dei coloranti. I locali catenesi si sono adeguati e hanno messo il pistacchio ovunque, a costo di deturpare ricette storiche o di aggiungere inutili calorie solo per attirare il turista bavarese affamato di pistacio.

E se non basta l’estetica per invogliare gli “osservatori del cibo”, arriva in soccorso l’abbondanza. I panini diventano più grandi, ci sono più strati di cheddar, l’hamburger si trasforma in smash burger e i condimenti strabordano dal pane. Si crea una sorta di megalomania culinaria. Un tempo l’essere umano sfidava Dio costruendo cattedrali sempre più alte; oggi panini sempre più grossi. È la sfida dei nostri tempi, alimentata anche dalle challenge su Internet con youtuber che si battono a chi mangia più roba o a chi lo fa più velocemente. È pieno di video con titoli come Mangio tutto il menu del McDonalds o Ecco il kebab più grande del mondo. Le dosi aumentano, gli osservatori pretendono di ingurgitare più cibo senza comunque spendere troppo, e dunque cresce a dismisura il numero degli all you can eat, che inevitabilmente abbassa la qualità favorendo la quantità. Da fenomeno del web diventa una realtà quotidiana, che sia per il sushi, l’aperitivo o un giro-pizza. Siamo talmente influenzati da ciò che vediamo da aver “costretto” il mercato ad adeguarsi e a offrirci prodotti simili a quelli bramati sui social. Perché non basta mangiarli, dobbiamo mostrarli come esperienza di riscatto: sono riuscito a prendere quella pizza gigantesca a due piani con una burrata-grattacielo, e se non te lo mostro in una storia non ha nemmeno senso ordinarla.

Non è neanche una questione di cibo meno sano. Sbagliano infatti certi nostalgici che criticano il fenomeno rimpiangendo il “buon cibo della nostra infanzia”. Non era sano nemmeno quello: le merendine di quando ero bambino avevano ingredienti che col tempo hanno dovuto togliere per motivi di salute o ambientali, e non mi riferisco per forza al trend dell’olio di palma ormai diventato meme. I prodotti confezionati di oggi sono paradossalmente più sani rispetto a quelli di venti o trent’anni fa. È tutto il contorno a essersi inabissato nell’esagerazione, nella pseudo opulenza di ingredienti in realtà non troppo dissimili dalla finzione delle pubblicità. Qualche conservatore attribuisce questo fenomeno anche a una presunta globalizzazione culinaria. Anche qui si va fuori dal vero senso del food porn, anche perché quando hanno provato a portare in Italia catene straniere che conoscevamo attraverso i film o i video sul web, non sempre è andata bene. Penso per esempio a Domino’s Pizza, costretta a chiudere perché gli italiani non erano antropologicamente adatti a quel tipo di prodotto, a un’americanità che non ci appartiene. Quindi il food porn con la pizza lo facciamo aggiungendo burrata-pistacchio-mortadella, forse anche perché ogni Paese ha la propria pornografia.

Il food porn sta al cibo come il wrestling sta allo sport. Nessuno vieta le recite di energumeni che fingono di picchiarsi, e ognuno ha il diritto di gradire lo spettacolo; allo stesso tempo non bisogna di certo creare un proibizionismo sul modo di approcciarci al cibo. Sarebbe però necessario capire come la qualità di un prodotto non sia legata all’apparenza di una foto sui social, ai filtri e ai trucchetti del mestiere per rendere più appetibile ogni oggetto vagamente commestibile. Altrimenti ci arrendiamo al trionfo dell’apparenza anche a livello culinario, modifichiamo in peggio le nostre abitudini alimentari e, ancora una volta, la diamo vinta al capitalismo. Perché il libero mercato miete vittime anche quando si parla di cibo affabulando le masse, e di questo passo una colata di pistacchio ci seppellirà.
L'articolo Una colata di pistacchio ci seppellirà proviene da THE VISION.
Qual è la tua reazione?