Il libro della moda anticapitalista: intervista all’autrice Tansy E. Hoskins
Smetteremo di produrre vestiti per rigenerare il Pianeta: è la visione della giornalista Tansy E. Hoskins in “Il libro della moda anticapitalista”.

- Nonostante il discorso sulla sostenibilità della moda occupi sempre maggiore spazio, il sistema globale di produzione di abbigliamento si basa ancora su uno sfruttamento eccessivo di risorse naturali, una decarbonizzazione troppo lenta e condizioni inique per le lavoratrici e lavoratori di tutto il mondo (circa 72 milioni di persone).
- La giornalista inglese Tansy E. Hoskins è esperta della filiera globale di produzione della moda e il suo ultimo libro è stato da poco tradotto in italiano: “Il libro della moda anticapitalista” (ed. Il Saggiatore).
- Il suo sguardo sul sistema moda globale l’ha portata a teorizzare un sistema completamente diverso, l’unico per lei sostenibile, che si basi sui principi della decrescita e dell’anticapitalismo. Una visione che prevede il blocco della produzione dell’abbigliamento, per lasciare tempo al Pianeta di rigenerarsi e a noi di “sistemare” i nostri armadi fin troppo pieni.
La moda è un atto politico. Lo pensano molti critici di costume e stilisti di fama, ma probabilmente non lo intendono alla stessa maniera di Tansy E. Hoskins, giornalista investigativa specializzata nella filiera globale della moda. Nell’ultimo libro della giornalista inglese, da poco tradotto in italiano per Il Saggiatore, lo esprime chiaramente fin dal titolo: “Il libro della moda anticapitalista – Tra Karl Lagerfeld e Karl Marx”.
Una soluzione radicale – proporre un sistema moda anticapitalista – perché radicali sono i problemi che affliggono questo settore, dallo spreco di risorse naturali ai diritti non rispettati delle lavoratrici e dei lavoratori, fino al razzismo e alla produzione incontrollata di rifiuti tessili che invadono il Sud del mondo, tutti punti affrontati da Hoskins capitolo per capitolo nel libro.
Il giudizio di Hoskins sul sistema moda attuale è impietoso (come lo era l’indagine sulla produzione di scarpe dell’altro suo libro “Lavorare con i piedi. Ciò che le tue scarpe stanno facendo al mondo”), ma è affascinante la previsione con cui conclude la sua lunga dissertazione. Dopo aver assistito all’avvento del fast fashion e poi dell’ultra fast fashion, Hoskins scrive: “Ritengo probabile che la produzione in massa dell’abbigliamento si interromperà completamente per anni così da consentire alla terra di rigenerarsi e a noi di operare una pulizia a fondo dell’industria, vagliare, classificare, riparare, riciclare e ridistribuire gli indumenti che già abbiamo. Molte di queste risorse saranno raccolte in magazzini di proprietà comune, il che determinerà una maggiore possibilità di accesso all’abbigliamento ma anche un restringersi dei guardaroba personali. Sorgeranno laboratori destinati alle riparazioni e alla manutenzione degli utensili dove condividere compiti e abilità, insieme a lavanderie pubbliche”.

Perché è arrivata a specializzarsi sulla filiera globale della moda?
Ho iniziato intorno al 2011 perché avevo molte domande e non trovavo risposte soddisfacenti. All’epoca non esisteva un movimento per la moda sostenibile, né così tanti articoli o podcast. Era ancora un settore piuttosto sconosciuto nei suoi meccanismi. Solo la giornalista inglese Lucy Siegle aveva già pubblicato qualcosa. Soprattutto, nessuno sembrava collegare direttamente alla moda la parola “capitalismo”, mentre per me era un collegamento fondamentale per spiegare molti meccanismi.
In italiano si dice “fatto a mano” per indicare un capo di alta sartoria, come se il resto del nostro guardaroba fosse prodotto da robot e non da esseri umani. Quando e come ci siamo distaccati da ciò che indossiamo tanto da non renderci quasi più conto delle persone che cuciono i nostri vestiti?
Ai brand piacerebbe moltissimo avere dei robot in grado di cucire e assemblare abiti al posto degli umani, ma al momento questo non accade. Tutto ciò che è dentro i nostri armadi o porta scarpe è fatto da un essere umano, tendenzialmente una donna in un Paese del cosiddetto Sud del mondo, che non riceve un salario dignitoso per vivere e che lavora in un contesto spesso dannoso per la sua salute o pericoloso per la sua sicurezza. Come siamo arrivati a dimenticarci di 72 milioni di persone nella filiera della moda? Credo sia stata una scelta deliberata farcene dimenticare. I brand non vogliono farci pensare alle fabbriche, ma venderci un’immagine ben precisa, legata a ciò che scelgono loro, che sia il fitness, il lusso, la sostenibilità.
Nel suo libro sembra sminuire l’evento del crollo del Rana Plaza nel 2013 come un punto di non ritorno sul tema della sicurezza dei lavoratori nella filiera moda. Perché?
Il crollo del Rana Plaza è stata una bomba esplosa nel cuore dell’industria moda. Ha distrutto per sempre l’idea che la moda fosse giusta, sostenibile, gentile, lussuosa o qualunque altra cosa. Doveva essere un momento di svolta. Doveva essere il momento in cui tutti i marchi avrebbero dimostrato di preoccuparsi davvero dei lavoratori dell’abbigliamento, dei diritti delle donne e così via. Ma la realtà è che, sebbene il Rana Plaza abbia reso le persone in tutto il mondo molto arrabbiate e sconvolte, non ha cambiato le pratiche di approvvigionamento dei marchi. Il grande cambiamento avvenuto è stato l’Accordo del Bangladesh sulla sicurezza antincendio e degli edifici, un’iniziativa guidata dai sindacati, che ha imposto un sistema di ispezioni nelle fabbriche in Bangladesh. Senza dubbio, grazie all’accordo, le fabbriche in Bangladesh oggi sono più sicure.
E durante gli anni della pandemia cosa è successo?
La pandemia è l’esempio perfetto del motivo per cui il Rana Plaza non è riuscito a cambiare l’industria della moda. I marchi hanno iniziato a cancellare ordini in tutto il mondo, persino ordini già completati o spediti. Dicevano semplicemente di non voler pagare o di voler uno sconto del 70, 80, 90%. A pagare il prezzo più alto di queste pratiche terribili sono stati i lavoratori. Ho parlato con donne che sono sopravvissute per mesi mangiando riso cosparso di sale. Molti non hanno potuto pagare le medicine o procurarsi cibo adeguato. Un rapporto della Asia Floor Wage Alliance ha evidenziato che i lavoratori della moda hanno affrontato la pandemia di fatto senza stipendi, senza lavoro, senza cibo, senza aiuti.
In Italia si tende ad auto-assolversi affermando che questo sia un problema solo di altri Paesi, quando recenti casi di cronaca hanno dimostrato che non è così. Ci si può ancora fidare dell’etichetta “Made in”?
Per me è un pezzo di stoffa senza significato, non assicura nemmeno che l’oggetto in questione sia stato interamente prodotto nel Paese indicato. Tempo fa ho visitato una fabbrica di scarpe in Macedonia, posto tremendo senza uscite di sicurezza, con finestre sbarrate e decine di donne pagate pochissimo. Era una specie di lavoro stagionale: venivano licenziate quando non c’erano ordini e poi riassunte. In tutta la fabbrica c’erano scatole con l’etichetta “Made in Italy”. Ho scoperto che questo è il risultato di un fenomeno chiamato “outward processing trade”, un escamotage nella legislazione dell’UE che consente alle merci di spostarsi in altri Paesi per alcuni processi produttivi. Le scarpe possono essere fabbricate in Macedonia, poi riportate in Italia per qualche piccola lavorazione finale, come la lucidatura, il confezionamento o l’inserimento dei lacci, e così possono essere etichettate come “Made in Italy”.
Un altro aspetto importante è che molte persone che lavorano nella filiera, anche dei marchi di lusso, devono firmare accordi di non divulgazione (NDA), per cui accadono molte cose terribili, ma è difficile scoprirle perché non possono parlarne. Ogni volta che viene condotta un’indagine sugli standard delle case di moda di lusso, queste aziende non ne escono mai bene, che si tratti di tasse, diritti dei lavoratori o sostenibilità.
Quali sono attualmente i Paesi con le condizioni di lavoro peggiori?
Difficile fare una classifica, sicuramente tutta l’Asia meridionale si trova in una situazione molto difficile, anche a causa della crisi finanziaria e delle agitazioni sociali. Penso a Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Myanmar. E il peso è particolarmente sentito dai lavoratori e lavoratrici dell’abbigliamento perché l’export è critico per loro, in Bangladesh l’80-90% dell’export è rappresentato dall’abbigliamento. La situazione è davvero grave in Myanmar, un Paese governato da una giunta militare, dove i salari sono particolarmente bassi e la libertà sindacale è inesistente.
Come possono i brand non avere consapevolezza di ciò che costituisce un salario dignitoso in un determinato Paese?
Lo sanno. Una giornalista come me o una qualsiasi ong può andare e scoprire quale sia il salario minimo per una vita dignitosa o commissionare uno studio, quindi figurarsi una multinazionale da miliardi di dollari di profitto. Al contrario, i team che si occupano di cercare fornitori cercano chi produce più velocemente e a minor costo, quindi proprio l’opposto di ciò che sarebbe giusto. Vogliono trovare le fabbriche che pagano salari da miseria, perché così i loro profitti sono più alti.
Nel libro sembra non credere molto al “voto con il portafogli”, ovvero alla forza che hanno i consumatori con le proprie scelte di acquisto di cambiare il sistema produttivo. Davvero non abbiamo nessun potere?
Penso che il potere delle persone sia assolutamente fondamentale. Qualsiasi cambiamento che abbiamo visto nell’industria della moda è stato il risultato di uno sforzo globale concertato. Ma nessuno di questi cambiamenti è avvenuto grazie a scelte di acquisto. I cambiamenti che abbiamo visto, ad esempio l’Accordo del Bangladesh sulla sicurezza o in India l’Accordo di Dindigul, che affronta la violenza di genere nello Stato del Tamil Nadu, sono tutti il risultato del lavoro congiunto e delle proteste delle persone in Italia, Europa, Stati Uniti, e delle persone in Bangladesh o India. Qui abbiamo i negozi dei marchi, le sedi centrali e un sistema di stampa libero che ci ascolta, quindi sicuramente abbiamo un ruolo fondamentale.
È stata coinvolta nel raggiungimento dell’Accordo di Dindigul (Dindigul Agreement) contro la violenza di genere nel 2022. Come si è arrivati al risultato?
Tutto è iniziato dopo l’omicidio di una lavoratrice tessile di 21 anni nel Tamil Nadu, di nome Jeyasre Kathiravel, che ha scoperchiato una realtà tremenda di violenze sistematiche contro le lavoratrici, in particolare donne Dalit, incluse molestie sessuali. In Gran Bretagna abbiamo organizzato manifestazioni intorno ai negozi H&M in tutto Regno Unito e una campagna social virale. Ci hanno seguito anche in altri Paesi europei e negli Stati Uniti, dove squadre di negoziatori lavoravano per sostenere le donne coinvolte nelle violenze in India, che si sono lentamente fatte avanti per denunciare un problema endemico. Ancora una volta, è stato il potere delle persone a cambiare le cose.
Dovremmo sottolineare maggiormente che l’insostenibilità del sistema moda sia un problema di genere?
Sì, nel libro esprimo chiaramente la mia visione. L’industria della moda punisce le donne, dalle contadine che coltivano il cotone alle operaie che lavorano in fabbrica. Alle modelle che vengono utilizzate nelle pubblicità fino alle clienti finali che acquistano i vestiti, facendole spesso sentire a disagio con se stesse per il proprio aspetto. E poi, quando la moda diventa un rifiuto, i raccoglitori di rifiuti e gli straccivendoli finiscono per smistarli in questo modo, e anche in questa ultima fase sono coinvolte principalmente donne. Le decine di miliardi di profitti che si realizzano ogni anno nella moda sono frutto della miseria delle donne. La violenza, poi, è un aspetto trasversale, che colpisce tutte, dalle modelle alle operaie.
Abbiamo visto arrivare il fast fashion, poi l’ultra fast fashion. Cosa ci dobbiamo aspettare dal futuro del sistema moda globale?
Nel libro cerco di esplorare alcuni orizzonti con delle previsioni anche provocatorie. Penso sia innegabile affermare che l’industria della moda cambierà perché attualmente è insostenibile. È basata sui combustibili fossili, per i tessuti e per i trasporti globali, su condizioni di lavoro inique, su una quantità di abiti insostenibile da reggere se vogliamo contrastare davvero il cambiamento climatico. Quindi o cambierà per il meglio, oppure crollerà insieme alla società come la conosciamo oggi. Francamente questa al momento mi sembra la direzione verso la quale ci stiamo dirigendo. Le temperature salgono implacabili, mentre i brand continuano a produrre miliardi di pezzi con vita brevissima, di cui non abbiamo bisogno. Per questo sostengo l’idea della decrescita per l’industria moda, perché produce per la maggior parte oggetti non essenziali e non necessari.
Cosa risponde alle persone che chiedono “e quindi cosa dovrei indossare”?
È frustrante anche per me ricevere spesso questa domanda. Dobbiamo concentrarci su ciò di cui abbiamo bisogno, non su ciò che le multinazionali vogliono farci acquistare. Le piccole decisioni su ciò che compriamo quotidianamente hanno un potere limitato. Fate il meglio che potete per compiere una scelta sostenibile. Lo scopo della vita non è creare un guardaroba perfetto, anche perché oggi nessuno può sentirsi a proprio agio con questi vestiti, perché di fatto non esiste una moda sostenibile sul grande mercato. Il nostro compito primario rimane lavorare con quelle 72 milioni di persone che attualmente sono schiavizzate dall’industria dell’abbigliamento.
Potremo tornare ad amare la moda?
Dobbiamo riflettere sul ruolo che vogliamo dare alla moda nelle nostre vite. Vogliamo vestiti belli, ben realizzati, che non danneggino chi li produce o il Pianeta dove viviamo, che raccontino la nostra identità, celebrino le nostre culture. Vogliamo che durino a lungo e che ci accompagnino nelle nostre vite. Nel momento in cui decidiamo che è questo lo scopo della moda, allora possiamo cambiare. Possiamo cambiare tutto. Possiamo fare in modo che Paesi come il Bangladesh, l’India, il Pakistan, il Myanmar, la Macedonia, smettano di avere l’intera economia basata sulle industrie esportatrici e iniziano anche a dire: “Ok, di cosa abbiamo veramente bisogno?”. Abbiamo 72 milioni di persone che lavorano nell’industria dell’abbigliamento, forse dobbiamo farle lavorare nella costruzione di difese contro le inondazioni, pannelli solari, scuole, ospedali, rigenerare terreni agricoli.

Qual è la tua reazione?
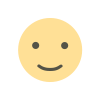
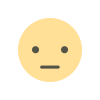

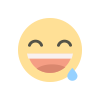

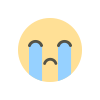






/https://www.webnews.it/app/uploads/sites/2/2025/01/g7-pro-di-realme____.jpg)











